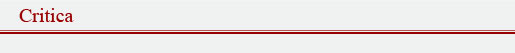
FERSEN
itinerario ininterrotto di un protagonista del Novecento
26 - 27 - 28 ottobre 2011
Biblioteca Vallicelliana di Roma
giovedì 27 ottobre
FERSEN E L'INVENZIONE DEL TEATRO EBRAICO
Maricla Boggio
Ho scelto di definire "invenzione del teatro ebraico", il tipo di lavoro sviluppato da Alessandro Fersen in tre spettacoli elaborati nel tempo a distanza di anni, addirittura di decenni l'uno dall'altro, perché questi tre spettacoli presentano delle caratteritiche di invenzione, pur mantenendosi fedeli ad una comune radice ebraica, attraverso elementi di novità che prendono evidenza a vari livelli, in un contesto di base persistente in tutti e tre gli spettacoli, a cominciare dal personaggio corale di una comunità.
Diversa la consistenza delle tre opere: "Lea Lebowitz", del 1947, è tutta incentrata su di una dimensione simbolica di spiritualità; "Golem", in scena nel 1969 al Maggio Musicale Fiorentino, trasse da antiche leggende medioevali la vicenda incentrata sul "robot" di argilla; tuttavia Fersen la portò ad epoca storica, nel XVI secolo, a Praga, sviluppando attraverso il contrasto fra ebrei e cristiani il tema che più gli stava a cuore, e cioè il rapporto problematico fra scienza e potere; "Leviathan", rappresentata al Festival di Spoleto nel 1974, in cui gli elementi dell'ebraismo risultano sfumati e attengono per certi versi a richiami biblici e per altri ad un sottofondo di interiorità tormentata emergente dal profondo dell'interiorità. Queste opere rappresentano diversi stadi della maturazione drammaturgica di Fersen, che realizzò i tre spettacoli inserendoli nella sua attività di regista e autore teatrale sviluppata nell'ambito del teatro di tradizione in Italia.
"Lea Lebowitz", il primo dramma, è andato in scena nel 1947. E' da poco finita la guerra, portandosi via gli orrori della deportazione che ha colpito in maniera tragica il popolo ebraico. Fersen è nato in Polonia, dove la comunità ebraica era folta e inserita nei costumi e nelle tradizioni del suo popolo; poco più che un bambino, era stato portato in Italia, a Genova, dove era rimasto fino alla laurea in filosofia; vari, negli anni successivi, i soggiorni a Parigi, a Varsavia, in Bielorussia e di nuovo in Italia, per la nascita della figlia Ariela; in lotta contro il nazismo e infine nella Resistenza, era approdato in Svizzera per sfuggire alle deportazioni; finalmente era poi tornato alla sua Genova, iniziando, insieme all'amico carissimo ritrovato a Losanna, lo scenografo Lele Luzzatti, a portare in scena i suoi primi spettacoli.
Erompe nel giovane, maturato dalle pesanti esperienze di vita, la voglia di esprimere un mondo acquisito nell'intimo che richiede, per farsi universale e atemporale, un linguaggio di metafore: la scelta inevitabile cade sul teatro, mezzo ideale per comunicare in maniera diretta e poetica il proprio mondo interiore a chi forse sa e forse non sa, e trasfondere negli altri le proprie angosce ma anche il proprio forte afflato di vita. Il dialogo profondo con Luzzatti è proficuo: dovrà venir fuori uno spettacolo teatrale del tutto speciale. Altri registi, con il vantaggio di una certa fama rispetto a loro, sconosciuti, hanno allestito rappresentazioni partendo da classici illustri. I due amici vanno alla ricerca di un testo nuovo, ma da nessuno di quelli letti e valutati emerge la forza espressiva che Fersen vorrebbe trarne e che fa sognare anche Luzzatti, sotto l'aspetto figurativo vero "doppio" dell'amico. Poiché questo testo vagheggiato non lo trova, Fersen decide di scriverselo lui, come Geppetto si costruì Pinocchio inserendo nella sua creatura tutti gli elementi del desiderio e del dolore, della consolazione e della trasfigurazione mediante il sacrificio, fino alla conclusione della storia; e Luzzatti lo segue e lo incoraggia offrendo forme ai suoi sogni.
"Lea Lebowitz" è una vicenda inventata, plasmata da Fersen sulla base di un'antica leggenda chassidica giunta fino a noi attraverso una lirica del poeta russo-palestinese Saul Cernikovskij e poi sviluppata attraverso elementi attinti dalla tradizione ebraica. Credo che il lavoro ferseniano di scrittura possa individuarsi non secondo parametri storici o antropologici in senso stretto, ma mediante il filo della memoria personale dell'autore, nella dimensione di quella archeologia del soggetto di stampo psicoanalitico che appartiene a ciascuno di noi e di cui soltanto una piccola parte emerge a consapevolezza. Fin dalla descrizione iniziale della scena appare una serie di riferimenti archetipici che richiamano un villaggio-ghetto dell' Europa Orientale. Un gruppo di case di legno, una sinagoga, una strada che si inerpica verso il cimitero: ecco un insieme di elementi che configurano la base sulla quale si costruisce l'esistenza di una comunità: è un mondo vagheggiato e lontano che appartiene alla memoria, come i dipinti evocati dai sogni dell'infanzia di certi villaggi chagalliani. Già fin dal sipario si entra nei simboli di una comunità ebraica attraverso cartelli incisi da disegni cabalistici. Ma proprio questo sipario induce alla metafora, all'indicazione di un racconto emblematico.
La vicenda, in sintesi. Nel villaggio, all'interno della sinagoga il giovane Eliel, futuro sacerdote, studia con dedizione assoluta: la sua giornata è tutta presa dalla lettura dei libri sacri. In una casa accanto al tempio Lea, una ragazzina destinata a sposare il figlio di un ricco mercante, spia Eliel concentrato sulla dottrina e se ne innamora. Eliel intuisce lo sguardo su di lui e ne viene distratto dai sacri testi, pur evitando di ricambiarlo. Mentre si sta per concludere il contratto di nozze di Lea, l'Angelo della Morte, inviato dall'Eterno, irrompe nel villaggio deciso a portar via Eliel nonostante che il destino del giovane sia di diventare un Rabbino. La comunità è sconvolta dal pericolo e il Rabbino capo, maestro di Eliel, mette in atto vari tentativi per salvare la vita del giovane, ma ogni espediente fallisce; si decide allora di far ricorso alla "raccolta degli anni": ciascuno offrirà una parte del tempo della sua esistenza per mantenere in vita Eliel, su cui poggiano le speranze della collettività. Dopo qualche offerta, più o meno generosa, chi offre la vita tutta intera è Lea: il suo sacrificio viene accettato e mentre lei sale la strada del cimitero, via via smorendo, Eliel riprende le forze tornando a vivere. A metà del cammino i due si incontrano, ma appena per un attimo: Eliel chiede a Lea il perché del suo sacrificio: lei risponde che è per fargli ancora godere la bellezza del mondo scritta nel libro sacro.
"Lea Lebowitz" si avvicina per molti versi al "Dibbuk" di An Sky, che Vachtangov mise in scena a Mosca nel 1921-22 dopo due anni di prove ottenendo un successo destinato a protrarsi per anni. Anche nel "Dibbuk" la scena si svolge in un villaggio ebraico in Polonia - ricordiamo la nascita di Fersen - e i personaggi vivono sotto certi aspetti la vicenda della "Lea Lebowitz"; inoltre anche nel "Dibbuk" la protagonista si chiama Lea.
Nel testo di An Sky, Hanan, che vive in una povera scuola sinagogale di giovani estatici nutriti di scritture, è innamorato di Lea e muore di dolore quando viene a sapere che la ragazza andrà sposa al figlio di un ricco mercante. La sua anima si impossessa del corpo della ragazza, e il giorno dello sposalizio lo spirito di Hanan urla attraverso la bocca di Lea il suo forsennato amore per lei, finché un santo Rabbi riesce a liberarla per via di esorcismi. Ma l'anima di Lea abbandona a sua volta il proprio corpo per seguire in cielo lo sposo che amava. Il "Dibbuk" è intriso di tradizioni e leggende chassidiche, e la lingua stessa - l'jiddisch, pieno di risonanze e tonalità variate - con cui fu rappresentato accresce il clima di mistero e di magia rivolto al soprannaturale e all'ultraterreno.
Nell'opera di Fersen, agli elementi di stretta derivazione ebraica se ne aggiungono però altri che rivelano l'appartenenza di Fersen ad un mondo culturalmente allargato: se il fanciullo Fersen ripensa oniricamente al ghetto polacco e, forse, alle leggende ascoltate nell'infanzia, l'intellettuale inserito nell'Italia liberata dalla dittatura fascista richiama alla sua fantasia ed inserisce nella sua drammaturgia il teatro dei classici - soprattutto quelli che corrispondono alla sua esigenza di metafora e di distanziazione atemporale -, come le Streghe del "Macbeth" o le Parche della tragedia greca. Ecco allora, ad apertura di sipario, presentarsi Tre Maschere - qui di sesso maschile - : esse aprono il dramma come un prologo, cantando che quando verrà il Messia si farà festa. Gli strumenti musicali con cui accompagnano il canto sono semplici: il Mendicante suona un violino, il Folle scuote un campanello, il Pellegrino dà fiato a una trombetta. Ai tre personaggi è naturlae attribuire dei significati simbolici: la povertà esemplare, al Mendicante in continuo viaggio; la pazzia sacra ma anche esistenziale dovuta al timore delle persecuzioni, al Folle; la ricerca della patria perduta, al Pellegrino. A questi tre si aggiunge un personaggio itinerante, certamente simbolo del perenne esilio di Israele: è il Venditore Ambulante, che esibisce oggetti anch'essi simbolici per lo sviluppo della vicenda: nastri per abiti da matrimonio, scialli da lutto o da festa: il suo vendere lo fa interlocutore ideale della popolazione al di là di ogni condizione sociale e tramite di comunicazione.
A questa panoramica di sfondo in cui agisce una comunità ebraica si integra la vicenda particolare. Lea, quindicenne benestante, di famiglia tradizionale, destinata ad un matrimonio di interesse combinato dal padre, è curiosa di ogni evento, desiderosa di libertà e di poesia, e per referente non ha che Sarah, la sua Nutrice: "Uno studioso della legge si può sposare?": ecco la domanda di Lea che apre il dramma. Perché la ragazza, promessa dal padre al figlio di un ricco mercante, ha "visto" Eliel e se ne è innamorata. Ma Eliel non è un giovane qualunque, appartiene alla Legge le cui profonde implicazioni deve apprendere prima di raggiungere la perfezione, e dal Rabbino che lo ha educato gli è stato destinato un posto altissimo nel Tempio, quando a studi compiuti lui sarà pronto. Da qui in poi si alternano nelle azioni e negli spazi quanto attiene a Lea e quanto a Eliel. C'è una sorta di compenetrazione fra lo spazio di Lea - la casa, il privato - e quello del Tempio, in cui Eliel porta avanti il suo studio, alternandolo alla meditazione, non sempre concentrata soltanto sulla Legge, ma sfuggente verso quel sentire a cui la sua gioventù non può rinunciare. Lea spia Eliel dalla sua finestra, ed Eliel da quello sguardo che non raccoglie, evitandolo come una tentazione, viene comunque trafitto e distolto da quanto gli è stato imposto come dovere.
L'invenzione drammaturgica ferseniana emerge attraverso le valenze allargate che assumono i protagonisti: in Lea si incarnano eroine appassionate del teatro di tutti i tempi, così come, in modo più contrastato, si adombrano in Eliel altrettanti personaggi. Impossibile non intravvedere nei due giovani una coppia dell'amore tragico come Giulietta e Romeo. E come non cogliere, attraverso le fasi successive della vicenda, forti riferimenti alla Alcesti di Euripide nel suo sacrificarsi ad Admeto? Come non sentire il sommesso profumo della Euridice di Rainer Maria Rilke a cui si contrappone Orfeo che dopo averla guardata se ne deve allontanare? Questi impercettibili ed evanescenti accostamenti fra la vicenda creata da Fersen ed i personaggi citati sono dovuti, a mio avviso, alla cultura introiettata dall'autore nella sua frequentazione del mondo occidentale, che nella personalità ferseniana si è trovata ad intrecciarsi alle sue origini di studioso certo anche di elementi di antropologia.
Che succede allora a questa potenziale coppia le cui entità umane sono destinate a rimanere divise? Il colpo di scena che devia da una soluzione radicalmente negativa o positiva è l'introduzione, da parte di Fersen, dell'Angelo della Morte inviato dall'Eterno per portar via Eliel, al di fuori di ogni previsione di vita che era stata riposta in lui, specie dal Rabbino che lo aveva scelto per sostenere la comunità. Qui si introducono altri elementi narrativi, di cultura ebraica ma anche cristiana. Il primo tentativo che la comunità mette in atto per salvare Eliel dalla morte - senza successo - è di impedire all'Angelo di attuare il compito affidatogli dall'Eterno cambiando il nome di Eliel in quello di Jehudà, in modo che l'Angelo vada altrove, alla ricerca di un altro essere il cui nome sia Eliel. Il dare un nome è un fatto di importanza determinante riguardo alla personalità di un individuo, è un riconoscimento che definisce, "nomina" la persona rispetto alla semplice nascita, ed è una funzione che viene compiuta dal padre in relazione al figlio nato da lui, che assume personalità autonoma e diventa componente della comunità. Ma qui non c'è un padre a nominare, e il tentativo non serve a salvare Eliel dalla morte. Analoga azione di scambio si rileva nella Bibbia, quando la madre fa credere a Isacco, cieco, di toccare il capo di Esaù, il primogenito, per benedirlo, mentre sotto la mano gli ha sostituito Giacobbe. Paer salvare Eliel, la comunità prova altri espedienti, che riportano a certe narrazioni favolistiche. Il Grande Rabbino manda al cimitero un gruppo di donne capeggiate da una di loro a misurare lo spazio fra le tombe: per seppellire Eliel dovrà esserci uno spazio adeguato alla sua importanza: se non lo troveranno, lui non potrà essere seppellito e quindi non potrà neanche morire. La logica indiscutibile di questo ragionamento supera la sua assurdità; e poiché le donne non trovano un posto degno per la sua sepoltura, ancora una volta Eliel rimane sospeso fra la vita e la morte. Occorre al più presto arrivare a una soluzione che impedisca all'Angelo di agire secondo gli ordini ricevuti dall'Eterno. Il quale tuttavia mostra margini di pietas, se la sua decisione ricevesse un'alternativa adeguata: è una sorta di prova di generosità, di altruismo e in definitiva di solidarietà degna di una comunità quella che l'Eterno richiede: non si sa come gli uomini siano a conoscenza di questa possibilità di scambio, ma intuisco in questo ultimo marchingegno echi del mito greco di cui certamente Fersen era compenetrato. L'ultima speranza della comunità per salvare Eliel è il "conto degli anni": ogni membro della comunità deve offrire un po' del suo tempo rinunciando quindi ad una parte di esistenza per far sì che Eliel recuperi la sua. Non è questo il tema centrale dell'"Alcesti" di Euripide? Admeto disperato chiede al padre, alla madre, all'amico del cuore di sacrificarsi per lasciarlo vivere, ma nessuno acconsente a donargli la vita, soltanto Alcesti sua moglie gliela offre tutta intera. Nella tragedia greca - l'unica che riporti un lieto fine, ma anche una morte in scena - è lo stesso personaggio destinato a morire - cioè Admeto - a chiedere lo scambio. La situazione drammatica è condensata da Rainer Maria Rilke in pochi versi che riportano con intensità alla tragedia classica, rinnovandola attraverso una sintesi di disperazione.
I versi sono ripresi dall'"Alcesti" de "Le nuove poesie":
"Ma egli ruppe la scorza del dolore
in pezzi e ne distese alte le mani,
come per trattenere il dio fuggente.
Anni chiedeva, solo un anno ancora
di giovinezza, mesi, pochi giorni,
ah, non giorni, ma notti, una soltanto,
solo una notte, questa notte, questa.
Il dio negava. Gridò allora Admeto,
gridò vani richiami a lui, gridò,
come gridò sua madre al nascimento".
Soltanto Alcesti, non richiesta, si offre allo scambio con lui. Questo stesso scambio avviene tra Lea ed Eliel; anche nel dramma di Fersen non c'è richiesta da parte del predestinato, e tuttavia lo scambio si compie per univoca volontà di Lea. Ciò che nella tragedia greca si verifica con strazio di entrambi i coniugi, nella vicenda nuova non ha riscontri legati ad una esistenza comune. Il sentimento è tutto immaginato, quindi vive in una astrazione di assoluta purezza e riguarda soltanto Lea. Ma quando i due si scambiano - teatralmente perché visivamente - i ruoli di morte e di vita scontrandosi sulla strada in un venire e un andare, il riferimento che affiora di nuovo, come una radice culturale emergente dalla memoria di Fersen, è il Rilke di "Orfeo Euridice Hermes" ancora da "Le nuove poesie"; qui però Euridice che scende nell'Ade è perduta a causa dello sguardo di Orfeo; non è lei a sacrificarsi volontariamente come Alcesti e come Lea, ma "viene sacrificata" dallo sguardo impaziente di Orfeo, suo compagno. E tuttavia anche Euridice, come Alcesti e come Lea, scende nell'Ade, mentre Orfeo continua a vivere, risalendo il cammino verso i vivi.
Ecco i versi di Rilke:
"Era in se stessa come un alto augurio
e non pensava all'uomo che era innanzi,
non al cammino che saliva ai vivi.
Era in se stessa, e il suo dono di morte
le dava una pienezza".
Ed ecco quanto scrive Fersen nella didascalia che descrive l'azione dello scambio fra vita e morte da parte di Lea e di Eliel.
"Lea sale ora lungo il viottolo che porta al cimitero. Dalla direzione opposta compare Eliel: si incontrano. Breve sosta."
ELIEL - ( con voce fioca) Lea... Perché?
LEA - ( con voce fioca) Perché tu possa ancora guardare i fiori, gli alberi, le nuvole che ci sono nel tuo grosso libro...
"Eliel si volge verso di lei, ma Lea abbassa il capo e riprende la sua strada. Mentre le due anime continuano ognuna il proprio diverso cammino, giù, nel Tempio, la preghiera dei fedeli si trasforma in un potente e trionfale inno di gloria".
Così finisce questa storia d'amore non vissuta, dove il sacrificio viene compiuto per far sì che si realizzi un percorso spirituale, in cui perfino i fiori e le nuvole sono evocati attraverso un libro sacro.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Calato in una realtà contrastata e polemicamente legato al problema morale della scienza che nelle mani del potere politico può degenerare è "Golem", del 1969. Fersen, attraverso il recupero di una antica vicenda in cui si adombra l'emulazione fra Dio e l'uomo che pretende di essere anche lui creatore, sposta il problema portandolo al rapporto fra la scienza creatrice e la responsabilità morale a cui essa deve attenersi mentre spesso vi trasgredisce, con un pericolo per l'umanità che già in alcune occasioni si è verificato in quei decenni, facendo temere per il futuro ancora più terribili catastrofi.
Il "Golem" originario parte da una leggenda medioevale che narra come l'uomo di creta a cui un saggio riesce a dar vita, si ribelli al suo artefice devastando il mondo al di là di ogni sua previsione. L'opera, ampio e difficile poema drammatico dello scrittore jiddisch Leiwik che richiese in Russia circa due anni di prove - dal 1924 al 25 -, si svolge nei tempi messianici durante la guerra tra Gog e Magog. Golem è un essere dimenticato dal mondo che giace da generazioni e sogna l'avvento del Messia. Quando si sveglia non è più argilla senza vita ma un essere nuovo e purificato; il suo sogno abbraccia i popoli oppressi, ed è lui che comincia a liberare il Messia buono. Ma l'anti Messia lo imprigiona e dopo una serie di lotte Golem verrà nuovamente liberato e gli verrà lasciata la sua esistenza terrena. Nell'opera, che venne rappresentata più volte e di cui si ricorda un'edizione molto applaudita a Parigi nel 1937, Golem viene presentato come il Gigante di creta; ma a differenza dell'edizione originale di Leningrado in cui era un grosso essere di animalesca cordialità, a Parigi, interpretato da Hana Provina, un'attrice nata quasi per caso, maestra d'asilo e rivelatasi di straordinaria espressività, assume i caratteri di una spiritualità terribilmente sofferente di Angelo condannato: i giudizi relativi a queste diverse forme di interpretazione provengono da un articolo su "L'arte della compagnia della Habima" scritto da Orazio Costa, che ebbe occasione di assistere allo spettacolo a Parigi.
Di tutto questo mondo mitico Fersen assume appena alcuni elementi di fondo. La vicenda da lui sviluppata si svolge nel XVI secolo, alla corte di Rodolfo II d'Asburgo, imperatore incerto e nevrotico, soggetto a crisi depressive, incerti comportamenti e accessi di follia. Emblematicamente Fersen ha scelto Praga e il Castello Reale di Hradscin - il Castello di Kafka - per descrivere il contrasto fra il popolo ebraico e la comunità cristiana come metafora degli ancora vivi nella memoria eccidi degli ebrei di marca nazista. Il Golem qui descritto viene a significare una minaccia per l'uomo futuro, come esperimento finalizzato al bene e poi rivolto alla distruzione degli esseri umani, una volta sfuggito al controllo del suo inventore: forse vi si ammanta anche la bomba atomica, e certamente si segnala il rischio della scienza di diventare schiava della politica nella sua volontà di asservimento. La trasposizione storica della leggenda medioevale diventa per Fersen ragione di moderna denuncia. Ecco una battuta assai significativa.
E' il saggio Rabbi Maharal a parlare all'imperatore:
"Che inquietante spettacolo offrono al giorno d'oggi i cosiddetti sapienti in ogni parte del mondo! Gli uni gareggiano fra di loro come se la scienza fosse un palio di Siena, in cui si tratti di arrivare primi al traguardo di una scoperta. Per gli altri la scienza non è molto più di un gioco: e non si preoccupano minimamente dell'uso che faranno dei loro 'giocattoli' i politici e i militari. Altri ancora, pur vagamente consapevoli delle responsabilità morali della scienza, soccombono prima o poi alle lusinghe del successo. E fingono allora di condividere ideologie, cui sono indifferenti o ostili".
Il Golem di Fersen, dopo essere stato un gigantesco servo obbediente a difesa del popolo ebraico nei confronti dell'imperatore sempre incerto fra benignità e repressione, è diventato feroce perché Hieronimus, lo scienziato dell'imperatore, ne ha manomesso la mente attraverso il furto dei sacri rotoli usati da Maharal per guidarlo, e con la sua forza selvaggia ha ucciso molta gente in città distruggendo tutto quanto ha trovato intorno a sé. E' lo stesso Maharal, alla fine, a decidere di rinunciare alla sua invenzione, perché la sua pericolosità supera la parte benefica.
Lo spettacolo, dopo aver debuttato al Maggio fiorentino, approdò l'anno seguente, il 1970, al Teatro Quirino di Roma. Giorgio Prosperi, critico principe di acuta capacità, ne scrisse dettagliatamente sul "Tempo", cogliendo in pieno il messaggio di Fersen. Ne riporto qualche riflessione essenziale:
" E' probabile che la leggenda del Golem, cioè di un prodigioso essere protettore, germogli nel subconscio collettivo delle comunità ebraiche così spesso decimate da scoppi di furore antisemita".
E più avanti scrive:
"L'apologo antiatomico ed antitecnocratico è trasparente. Ma Fersen non perde mai coscienza di aggirarsi nel terreno dell'utopia, e pertanto mantiene rigorosamente la sua storia, nonostante i personaggi siano realmente esistiti, nel campo della favola esemplare, anzi dell'oratorio e del rito. L'utopia resta confinata pertanto nella sua atmosfera onirica, come un sogno che la realtà distrugge come sogno, anche se non può respingerla come continua tensione verso un ideale".
Il dramma si conclkude con la battuta di Maharal:
"Oggi i tempi non sono ancora maturi per queste cose. Bisogna pure che un sapiente si levi a dire no al potere e abbia la forza di distruggere la propria opera. Si tratta ormai di decidere se la sapienza deve rassegnarsi aduna condizione cortigiana rispetto al potere offrendogli i suoi servigi ed eseguendone docilmente le commissioni. Oppure se essa deve rivendicare la sua antica indipendenza, in nome dei superiori principi spirituali che l'hanno ispirata alle sue origini. Io ho fatto il Golem e l'ho disfatto. Fra tre o quattro secoli, quando finalmente imperialismo, razzismo, schiavitù del corpo e dello spirito, saranno dimenticate, un nuovo sapiente lo resusciterà e lo governerà col consenso di tutti gli uomini. Fino allora il Golem dorma il suo sonno di argilla sotto le vecchie pergamene della legge e sotto i volumi della Kabbalà nel solaio della Scuola Talmudica di Praga".
Risalta in questa accorata battuta il senso tragico di un'epoca non ancora pacificata e rasserenata. Fersen avverte il pericolo di nuovi massacri, e da intellettuale si pone in una posizione di consapevole volontà di allontanarne le possibilità, questa volta anche avvalorate da scoperte scientifiche apparentemente positive.
A rendere chiaro il suo pensiero, che non si limita ad essere quello di un artista uomo di teatro, ma che diventa doverosa coscienza morale dell'umanità, l'autore aggiunge ancora in scena, con forte senso di pathos, la lamentazione del Muro del Pianto, mentre le Voci riprendono a sibilare:
VOCI - Dagli all'ebreo!
Popolo di Praga è tempo di dire "Basta! Basta alla congiura mondiale del giudaismo per lo sterminio della cristianità!".
Bruciate le Sinagoghe, profanate i cimiteri, annientate i nemici della croce!
Dagli all'ebreo! Dagli! Dagli! Dagli!
E lo spettacolo si conclude con la lamentazione del Muro del Pianto che risuona potente nel Ghetto, mentre si spengono le luci.
"Golem" è un complesso lavoro scandito in quadri, dove si fronteggiano ebrei e cristiani, uomini di religione e uomini di potere. E' il mondo che Fersen ha sperimentato durante l'epoca nazista ed è il teatro che sente di esprimere in questa fase della sua esistenza, come liberazione da un incubo dove elementi della cultura ebraica persistono nel suo immaginario, arricchendosi di significati contemporanei; è un teatro che mette a fuoco il problema della responsabilità morale della scienza e del potere nei confronti dell'umanità.
Vorrei fare soltanto un accenno a proposito di "Leviathan", ultima opera realizzata da Fersen attraverso richiami riconducibili ad un universo di ebraicità. Nel 1974 il Maestro ha da anni animato la sua scuola, nella quale sperimenta il suo mnemodramma in momenti di particolare concentrazione e sintonia con gli allievi con cui ha maturato un più stretto contatto artistico. E' una esperienza pluridecennale che Fersen mette a frutto componendo "Leviathan". Attraverso la lettura del copione e dalle dichiarazioni dello stesso Fersen, esso è il risultato dell'insieme di momenti di rappresentazione scelti via via nel corso di mesi di lavoro con i giovani allievi, improntato alla sperimentazione del mnemodramma. L'elemento scatenante del viaggio negli strati profondi della psiche che caratterizza questo metodo di lavoro è un semplice attrezzo, che funge da oggetto rituale e che assume a seconda del rapporto psichico che viene a crearsi con l'attore le più diverse significazioni. In questo senso si può forse fare riferimento a forme di ritualità accostabili ad una forma di cultura ebraica; tuttavia queste manifestazioni espressive si realizzano in maniera naturale, avulsa da elementi rapportabili a rituali jiddisch o a vicende riconducibili a tale cultura.
Il titolo dell'opera richiama l'antico mostro destinato a risorgere contrastando in maniera apocalittica l'uomo, e appartiene al patrimonio culturale ebraico; ma delle vicende che potrebbero riportarlo narrativamente in scena, poco o niente appare nello spettacolo ferseniano. Sono i giovani allievi a dar vita al mostro, diventandone parte ed agendo in sintonia attraverso gli attrezzi da loro maneggiati. Tutto il testo - composto in base a quanto avvenuto nel suo svilupparsi spontaneo - è organizzato da Fersen come serie di scenein un momento successivo alla rappresentazione, e tenendo conto di essa secondo quanto avvenuto. Le citazioni da testi classici, a partire dalla Bibbia passando alle tragedie greche, a citazioni in ebraico e così via, intessono un fitto e composito intreccio di suoni in cui le parole non valgono per il loro significato ma per il suono prodotto, mentre le azioni si susseguono sostenute dall'uso degli attrezzi. Una varietà innumerevole di simboli affiora via via nelle scene; ci si trova davanti all'impossibilità di una vera e propria comunicazione - i fili dei telefoni degli interpreti si intrecciano confusamente, infine vengono tagliati - , Caino emerge dalla massa e ricorre più volte la sua voce: "Sono forse io il guardiano di mio fratello?", richiamo incombente ad una civiltà di sangue che parte dalle origini dell'umanità. Lamenti corali in greco si sovrappongono mentre il gruppo scompostamente combatte... Ma è difficile tener dietro descrittivamente in maniera efficce alla complessità simbolica della rappresentazione, che a noi che tentiamo di rivederla con gli occhi della conoscenza del lavoro di Fersen e con l'aiuto di un copione-traccia pare tuttavia sdipanarsi da una ebraicità dolorosa e consapevole delle sofferenze patite. Tuttavia la conclusione non è più minacciosamente proiettata al dilemma della scienza e del potere, e della vittoria dell'una sull'altro o viceversa, come per "Golem", né si ritrae in un universo onirico di esaltata poesia come per la "Lea Lebowitz". Qui prevale un intento giocoso e giovane. Il feticcio del Leviathan costruito dagli attori cresce gonfiandosi paurosamente, ma le parole a lungo scomposte e frammentate vengono via via prendendo forma e significato.
Riporto le didascalie e le battute che concludono lo spettacolo:
"Dicono le VOCI:
'Non sai tu che è giunto il tempo di entrare nelle fauci del Leviathan?'.
Alla fine, quando l'interrogativo raggiunge un parossismo ossessivo, il Leviathan esplode. Le scale che costituivano le strutture portanti del feticcio vengono scagliate a distanza; tramortiti e attoniti i sopravvissuti si guardano in giro quasi scoprissero una verità antica, una condizione originaria dell'uomo da tempo dimenticata.
Ben presto si abbozzano alcuni richiami vocali, simili a quelli che hanno accompagnato la scoperta della voce umana. Gli attrezzi primitivi - corde e legni - vengono raccolti da terra: le corde vengono di nuovo lanciate e i legni stesi come un'offerta di incontro e contatto umano. Riprende l'antico gioco in un crescendo di gioia, ritmato dal "solfeggio in azione e voce". Al colmo del gioco cadenzato da risa, canti e parole, si produce un silenzio. Una voce pronuncia la frase conclusiva dello spettacolo:
VOCE - Dopo aver popolato il pianeta settanta milioni di anni fa, i dinosauri scomparvero ( per sempre) dalla superficie della terra".
E con la speranza riposta in quel "per sempre" che riguarda metaforicamente non il bestione preistorico, ma ogni specie di mostro rivolto ad attentare all'umanità, lo spettacolo si conclude in una dimensione liberata dall'angoscia e rivolta ad uno spirito di festosa collaborazione con i giovani attori.
L'anno successivo, il 1975, Fersen accettò di dirigere il Teatro Stabile di Bolzano. Si portò appresso "Leviathan" che riprese in quell'anno, quasi ponte sospeso fra un teatro gelosamente preparato in segreto, e un teatro di tradizione italiana, per di più calato in un istituto stabile obbligato a rappresentazioni adeguate ad un pubblico di media cultura e di varia estrazione. L'arco delle sue creazioni ebraiche si era compiuto. Gli sarebbe restata, sempre, in ogni altra rappresentazione avesse realizzata, l'ironia tipica della sua cultura di fondo, e sotto un'allegria talvolta anche festosamente chiassosa e variopinta, una vaga malinconia di antiche stagioni.
Desidero ringraziare in modo particolare Gian Domenico Ricaldone responsabile dell'Archivio del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, per avermi fornito i testi su cui ho lavorato.
